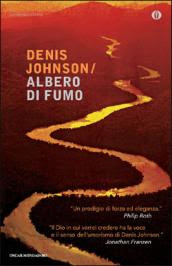Visualizzazione post con etichetta My translations: Denis Johnson. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta My translations: Denis Johnson. Mostra tutti i post
sabato 14 dicembre 2019
Post autopromozionale
Buona domenica! Se vi capita date un'occhiata all'inserto La Lettura del Corriere. Ci troverete il mio solito faccione.
mercoledì 24 aprile 2013
Train Dreams, di Denis Johnson

"Al
tramonto la sua avanzata si interruppe. Era fermo sull’orlo di un dirupo. Aveva
trovato una strada alternativa attraverso una specie di anfiteatro che
racchiudeva uno specchio d’acqua chiamato Spruce Lake, e ora lo stava
guardando, decine di metri sotto di lui, la superficie piatta immobile e nera
come ossidiana, circondata dall’ombra dei dirupi circostanti, accerchiata dalla
doppia cerchia dei sempreverdi e del loro riflesso. Più in là vide le Montagne
Rocciose canadesi dalle cime innevate, ancora illuminate dal sole, a
centocinquanta chilometri di distanza, come se la terra fosse nel bel mezzo
della creazione e le
montagne si stessero
materializzando dalle nuvole. Non aveva mai visto un panorama così maestoso. Le
foreste che gli riempivano la vita erano così popolose e alte che di solito gli
impedivano di vedere quanto fosse lontano il mondo, ma in quel momento gli fu
chiaro che c’erano montagne a sufficienza perché ciascuno avesse la propria."
Esce in questi giorni Train Dreams, la novella del grande Denis Johnson che ho tradotto per Mondadori.
sabato 5 marzo 2011
Denis Johnson/3: "Starlight, Idaho" e "Nessuno si muova"
L'anno scorso la rivista Vice Magazine, per il suo Quarto Annuale di Narrativa, ha pubblicato il racconto Starlight, Idaho, con una divertente prefazione che si conclude così: "Secondo noi, Johnson è lo scrittore di prosa più evocativa, poetica e potente al mondo. È uno dei pochi scrittori capaci di trasportarti in uno stato di coscienza trascendentale con il semplice uso delle parole. È, molto semplicemente, il migliore che c’è, e vorremmo sposarlo. Quando Denis ci ha permesso di tradurre questo meraviglioso racconto, apparso per la prima volta nell’edizione americana di Playboy nel febbraio del 2007, siamo stati così felici che abbiamo sacrificato una stagista vergine per ringraziare gli dei. Buona lettura."
(Quelli di Vice adorano Denis Johnson. Tim Small, nella sua recensione a Albero di fumo, sostiene "che non recensire Albero di fumo oggi sarebbe come se il direttore di una rivista nel 1852 decidesse di non recensire Moby Dick". Il resto della recensione qui, in fondo alla pagina: http://www.viceland.com/it/a5n4/htdocs/literary-it.php)
| Denis Johnson (photo by Cindy Johnson) |
Starlight, Idaho comincia così:
"Cara Jennifer Johnston, bene,
per aggiornarti su come vanno le cose, negli ultimi quattro anni ho preso un bel po’ di calci nel culo. Cerco di tornare a quando ero in quinta elementare e tu mi hai mandato un bigliettino con sopra un cuore e le parole 'Caro Mark mi piaci un sacco' e io l’ho girato e ho scritto sul retro 'Ti piaccio o mi ami?' e tu hai disegnato venti cuori su un altro bigliettino e me lo hai mandato in fondo alla fila e diceva 'Ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo!' Credo di avere quindici o sedici ami nella pancia, ciascuno con attaccata una lenza che finisce in mano a una persona che non vedo da tanto tempo, e fra queste ci sei anche tu. Ma tanto per aggiornarti. Negli ultimi cinque anni mi hanno arrestato più o meno otto volte e sparato due volte, non due volte nella stessa circostanza, ma una volta in due circostanze diverse, ecc ecc e mi sembra che una volta mi abbiano anche investito, ma non me lo ricordo nemmeno. Ho amato all’incirca duemila donne, ma credo che tu sia la numero uno della lista. Questo è tutto gente, passo e chiudo."
E continua qui: STARLIGHT, IDAHO - di Denis Johnson, Traduzione di Silvia Pareschi - Vice Magazine
E continua qui: STARLIGHT, IDAHO - di Denis Johnson, Traduzione di Silvia Pareschi - Vice Magazine
Luntz era uno dei quattro solisti. Firefly era venuta abbastanza bene, gli sembrava. Erano andati all’unisono sulle vocali, non avevano calcato le consonanti, e Luntz sapeva di essere apparso – lui, almeno – radioso e sorridente, con una gestualità molto espressiva. Su If We Can’t Be the Same Old Sweethearts avevano preso l’onda. Uniformità, sonorità, pathos, tutto quello che Rob poteva desiderare. Non l’avevano mai eseguita così bene. Poi, fronte a destra e giù dalle scale, erano scesi nel seminterrato del centro congressi, dove si erano schierati di nuovo in file parallele, questa volta per le foto ricordo."
giovedì 24 febbraio 2011
Denis Johnson/2: Albero di fumo, ancora un romanzo sul Vietnam
Ripubblico qui un mio articolo comparso sull’Indice dei libri del mese nell'aprile del 2009, sul romanzo di Denis Johnson Albero di fumo, da me tradotto per Mondadori. (Il link all'articolo non si trova, perciò lo posto qui per intero.)
Ancora un romanzo sul Vietnam
La domanda che ritorna spesso quando si parla di Tree of Smoke, il poderoso romanzo con il quale Denis Johnson ha vinto il National Book Award 2007, è se fosse necessario un altro romanzo sul Vietnam. La risposta è sì, per molteplici ragioni. La prima è che Tree of Smoke – dedicato a HP, che sta, molto probabilmente, per Higher Power – è un romanzo in cui la guerra del Vietnam si espande fino a diventare un simbolo di tutti i conflitti combattuti in nome di un Potere Superiore, umano o divino (“albero di fumo” è un’espressione tratta dalla Bibbia che viene usata in riferimento al fungo atomico nell’oscuro complotto spionistico che fa da sfondo al romanzo), fra i quali è possibile riconoscere anche l’attuale guerra contro l’Iraq. Anche qui, infatti, come nelle opere precedenti di Denis Johnson, i protagonisti sono anime smarrite che brancolano in un mondo di calvinistica predeterminazione, dove “alcuni erano sicuramente e assolutamente scelti per la salvezza, mentre altri erano altrettanto assolutamente destinati alla rovina”. Soprattutto, in Tree of Smoke, la guerra del Vietnam torna come traguardo di un filo conduttore che percorre, più o meno marginalmente, tutte le opere di Denis Johnson, da Angels (1983), in cui viene tracciata la tragica parabola post-bellica dei due fratelli James e Bill Houston, che tornano come protagonisti di Tree of Smoke, a Fiskadoro (1985), romanzo post-apocalittico in cui compare brevemente un altro dei protagonisti di Tree of Smoke, il vietnamita Nguyen Minh, che ritroveremo anche in Resuscitation of a Hanged Man (1991) insieme a Jimmy Storm, un altro personaggio del romanzo, e così via, in un rincorrersi di echi che trasformano Tree of Smoke in un prisma nel quale si riflettono i temi e i personaggi di tutta l’opera precedente di Johnson.
Diventa così possibile leggere il romanzo alla luce dei topoi della letteratura americana sul Vietnam, ripercorsi, reinterpretati e talvolta sovvertiti dall’autore. La struttura generale della narrazione, innanzitutto, in cui la frammentarietà e l’abbandono della linearità cronologica riecheggiano l’allucinazione della guerra, con l’alternanza fra le esplosioni adrenaliniche delle battaglie e le lunghe attese fra uno scontro e l’altro, ricorda immediatamente quella grande opera di New Journalism che è Dispatches di Michael Herr (1977), ma anche The Things They Carried di Tim O’Brien (1990) e The Short Timers (1979) di Gustav Hasford, romanzo dal quale venne tratta, con la collaborazione dello stesso Michael Herr, la sceneggiatura di Full Metal Jacket. Se le atmosfere surreali di quest’ultimo si ritrovano in molte scene del libro, un’altra potente eco cinematografica in Albero di Fumo è quella di Apocalypse Now, di cui ancora una volta Michael Herr fu co-sceneggiatore. La figura del Colonnello Francis Xavier Sands, eroe della Seconda Guerra Mondiale e scheggia impazzita negli alti ranghi dell’Agenzia, non è infatti altro che una nuova incarnazione del Kurtz conradiano: “E comunque la guerra è al novanta per cento mito, no? Per portare avanti le nostre guerre le eleviamo al livello di sacrificio umano, e invochiamo costantemente il nostro Dio. Nella guerra deve esserci qualcosa di più grande della morte, altrimenti saremmo tutti disertori. Penso che dovremmo esserne molto più consapevoli. Penso che dovremmo invocare anche gli dei del nemico. E i suoi demoni. Il nemico ha più paura delle sue divinità e dei suoi demoni di quanta ne avrà mai di noi.” Ma il Colonnello di Johnson, distorto attraverso la lente dell’ironia postmoderna, si trasforma in un personaggio ai limiti del grottesco, la cui iniziale immensità viene sminuita da una fine oscura e probabilmente indegna della sua fama mitica.
La lingua usata da Johnson è la stessa che accompagna tutta la letteratura e la cinematografia sul Vietnam: da un lato la lingua burocraticamente oscura dei vertici militari, dall’altro il gergo dei soldati, lo slang afroamericano dal ritmo sincopato, la lingua drogata e allucinata di uomini che, come in Herr, vedono la realtà intorno a sé ma non riescono a dare un senso alle immagini depositate nel loro cervello. La rivisitazione di temi e luoghi non può non comprendere il piacere della violenza, la follia omicida che assume i contorni della tortura di un presunto vietcong o dello stupro e omicidio di una donna vietnamita. E tuttavia nel Vietnam di Johnson non vi è spazio per le semplificazioni: “Buttavano bombe a mano dentro le capanne amputando braccia e gambe a contadini ignoranti, salvavano cuccioli affamati e se li portavano a casa, in Mississippi, nascosti sotto la camicia, incendiavano interi villaggi e violentavano bambine, rubavano jeep cariche di medicine per salvare la vita agli orfani.”
Il romanzo di Johnson, dunque, può essere visto come la rivisitazione di un genere, nella quale i luoghi comuni del genere stesso vengono evitati grazie all’ironia o alla intensa capacità di comprensione umana dell’autore. È questo il caso di un altro cliché della letteratura sul Vietnam: l’invisibilità del nemico. In Tree of Smoke scompare infatti la visione etnocentrica di “Charlie” (a cui era sfuggito forse solo Robert Olen Butler, con i racconti A Good Scent from a Strange Mountain del 1992, i cui protagonisti sono vietnamiti emigrati in America), e i personaggi vietnamiti diventano un elemento fondamentale del romanzo, al quale aggiungono profondità e interesse.
E così, in contrasto con la fondamentale misoginia della letteratura di guerra in generale e di quella sul Vietnam in particolare, Johnson affida la scena e il senso finale del romanzo a una donna, la missionaria Kathy Jones, che conserva l’estrema speranza di una salvezza raggiunta malgrado la disperazione, o forse proprio grazie a essa. “Kathy sedeva in mezzo al pubblico pensando: qualcuno qui ha il cancro, qualcuno ha il cuore spezzato, qualcuno ha perduto l’anima, qualcuno si sente nudo e straniero, pensa che un tempo conosceva la strada ma adesso non la ricorda più, si sente solo e privo di corazza, fra queste persone c’è qualcuno con le ossa rotte, altri che prima o poi se le romperanno, persone che hanno rovinato la propria salute, adorato le proprie menzogne, sputato sui propri sogni, voltato le spalle alle proprie convinzioni, sì, sì, e tutti saranno salvati. Tutti saranno salvati. Tutti saranno salvati.”
martedì 22 febbraio 2011
Denis Johnson/1: "Albero di fumo" e la morte della scimmia
"I'm gonna make the best of this fuck-a-monkey show."
Quello che segue è un estratto dal primo capitolo del romanzo di Denis Johnson, Albero di fumo, da me tradotto per Mondadori nel 2009. Tradurlo non è certo stata una passeggiata, ma è stata anche una grossa soddisfazione. Un libro poderoso, gigantesco, imperfetto e a tratti ostico, ma anche, come ha scritto Emanuele Trevi sul manifesto, "una pietra miliare, un passo avanti irrinunciabile nelle vicende del romanzo contemporaneo". Traducendolo ho dovuto fare i conti con uno stile "tutto sbalzi e cambi di marcia", come lo chiama Trevi, ma anche con uno slang spinto, reinventato, con una poetica e un immaginario personalissimi e al contempo imbevuti dell'atmosfera psichedelica della letteratura e della filmografia sul Vietnam.
Pubblico qui di seguito un estratto dal primo capitolo del libro, una delle scene più potenti e folgoranti che mi sia mai capitato di leggere.
Massimo Raffaeli ha scritto, su "Alias" del 9 maggio 2009 (perdonate l'autopromozione): "Ma colpisce, in un romanzo tanto esorbitante,
il carattere di serietà o di tangibile necessità che il manierismo di Johnson
testimonia appieno anche nella versione di Silvia Pareschi, sul serio
ammirevole per adesione all'impervia partitura originale, tutta sbalzi e cambi
di marcia. In chi legge è costante la sensazione che sia in gioco non tanto la capacità di
assolo di un virtuoso quanto l'etica di uno stile e, dunque, il fondamento di
una verità nel mondo della procurata mistificazione."
Pubblico qui di seguito un estratto dal primo capitolo del libro, una delle scene più potenti e folgoranti che mi sia mai capitato di leggere.
Appoggiò il fucile contro un banano rachitico, si tolse la fascia dalla fronte, la strizzò e la usò per asciugarsi la faccia e cacciar via le zanzare, fermandosi un po’ a grattarsi distrattamente l’inguine. Lì vicino, un gabbiano sembrava impegnato in una lite con se stesso, una serie di strida di protesta interrotte da grida più cupe, una specie di huh, huh, huh! E qualcosa che si spostava da un albero all’altro attirò l’attenzione del marinaio Houston.
Continuò a fissare il punto in cui aveva visto quella cosa, fra i rami di un albero della gomma, allungando la mano verso il fucile senza distogliere lo sguardo. La cosa si spostò di nuovo. Ora si accorse che si trattava di una specie di scimmia, non molto più grande di un chihuahua. Non era esattamente un cinghiale, ma si offriva comunque all’attenzione, mentre, aggrappata con la mano sinistra ed entrambi i piedi al tronco dell’albero, graffiava la corteccia sottile con minuscola, esasperata premura. Il marinaio Houston inquadrò nel mirino la schiena ossuta della scimmia. Alzò la canna di qualche grado e mirò alla testa. Senza davvero riflettere, tirò il grilletto.
La scimmia si appiattì contro l’albero, allargando braccia e gambe con aria entusiasta, poi si portò le mani dietro la schiena come per grattarsi e precipitò a terra. Il marinaio Houston assistette con terrore alle sue convulsioni. La scimmia si drizzò facendo leva sul braccio, poi si mise a sedere con la schiena contro l’albero, a gambe divaricate, come per riposare dopo un lavoro faticoso.
Il marinaio Houston si avvicinò di qualche passo e, da pochi metri di distanza, vide che aveva il pelo molto lucido, tendente al rosso henné all’ombra, e al biondo sotto la luce che filtrava tra le foglie in movimento. Si guardava intorno, respirando a grandi singulti ravvicinati, e ogni respiro le gonfiava enormemente la pancia, come un pallone. Il proiettile l’aveva colpita in basso, uscendo dall’addome.
Il marinaio Houston sentì lo stomaco lacerarsi. «Gesù Cristo!» urlò alla scimmia, come se le sue parole potessero modificare quell’imbarazzante e odiosa situazione. Pensò che gli sarebbe scoppiata la testa, se il mattino avesse continuato a bruciare la giungla circostante, se i gabbiani avessero continuato a gridare, se la scimmia avesse continuato a guardarsi intorno con circospezione, muovendo la testa e gli occhi neri da una parte all’altra come per seguire lo sviluppo di una discussione, di una disputa, di un litigio che la giungla, il mattino, il momento stavano conducendo con se stessi. Il marinaio Houston si avvicinò alla scimmia, posò il fucile lì accanto e la sollevò, con una mano sotto le natiche e l’altra sotto la testa. Si accorse, dapprima rapito, poi orripilato, che l’animale stava piangendo. Aveva il respiro rotto dai singhiozzi, e le lacrime gli sgorgavano dagli occhi a ogni battito di palpebre. Guardava qua e là, senza mostrare un particolare interesse per il marinaio. «Ehi» disse Houston, ma la scimmia non parve sentirlo.
Mentre la teneva in braccio, il suo cuore cessò di battere. Houston la scrollò, ma capì che era inutile. Ebbe la sensazione di essere colpevole di tutto, e lì, al riparo da sguardi indiscreti, si lasciò andare e pianse come un bambino. Aveva diciott’anni.
Iscriviti a:
Post (Atom)