"I'm gonna make the best of this fuck-a-monkey show."
Quello che segue è un estratto dal primo capitolo del romanzo di Denis Johnson, Albero di fumo, da me tradotto per Mondadori nel 2009. Tradurlo non è certo stata una passeggiata, ma è stata anche una grossa soddisfazione. Un libro poderoso, gigantesco, imperfetto e a tratti ostico, ma anche, come ha scritto Emanuele Trevi sul manifesto, "una pietra miliare, un passo avanti irrinunciabile nelle vicende del romanzo contemporaneo". Traducendolo ho dovuto fare i conti con uno stile "tutto sbalzi e cambi di marcia", come lo chiama Trevi, ma anche con uno slang spinto, reinventato, con una poetica e un immaginario personalissimi e al contempo imbevuti dell'atmosfera psichedelica della letteratura e della filmografia sul Vietnam.
Pubblico qui di seguito un estratto dal primo capitolo del libro, una delle scene più potenti e folgoranti che mi sia mai capitato di leggere.
Massimo Raffaeli ha scritto, su "Alias" del 9 maggio 2009 (perdonate l'autopromozione): "Ma colpisce, in un romanzo tanto esorbitante,
il carattere di serietà o di tangibile necessità che il manierismo di Johnson
testimonia appieno anche nella versione di Silvia Pareschi, sul serio
ammirevole per adesione all'impervia partitura originale, tutta sbalzi e cambi
di marcia. In chi legge è costante la sensazione che sia in gioco non tanto la capacità di
assolo di un virtuoso quanto l'etica di uno stile e, dunque, il fondamento di
una verità nel mondo della procurata mistificazione."
Pubblico qui di seguito un estratto dal primo capitolo del libro, una delle scene più potenti e folgoranti che mi sia mai capitato di leggere.
Appoggiò il fucile contro un banano rachitico, si tolse la fascia dalla fronte, la strizzò e la usò per asciugarsi la faccia e cacciar via le zanzare, fermandosi un po’ a grattarsi distrattamente l’inguine. Lì vicino, un gabbiano sembrava impegnato in una lite con se stesso, una serie di strida di protesta interrotte da grida più cupe, una specie di huh, huh, huh! E qualcosa che si spostava da un albero all’altro attirò l’attenzione del marinaio Houston.
Continuò a fissare il punto in cui aveva visto quella cosa, fra i rami di un albero della gomma, allungando la mano verso il fucile senza distogliere lo sguardo. La cosa si spostò di nuovo. Ora si accorse che si trattava di una specie di scimmia, non molto più grande di un chihuahua. Non era esattamente un cinghiale, ma si offriva comunque all’attenzione, mentre, aggrappata con la mano sinistra ed entrambi i piedi al tronco dell’albero, graffiava la corteccia sottile con minuscola, esasperata premura. Il marinaio Houston inquadrò nel mirino la schiena ossuta della scimmia. Alzò la canna di qualche grado e mirò alla testa. Senza davvero riflettere, tirò il grilletto.
La scimmia si appiattì contro l’albero, allargando braccia e gambe con aria entusiasta, poi si portò le mani dietro la schiena come per grattarsi e precipitò a terra. Il marinaio Houston assistette con terrore alle sue convulsioni. La scimmia si drizzò facendo leva sul braccio, poi si mise a sedere con la schiena contro l’albero, a gambe divaricate, come per riposare dopo un lavoro faticoso.
Il marinaio Houston si avvicinò di qualche passo e, da pochi metri di distanza, vide che aveva il pelo molto lucido, tendente al rosso henné all’ombra, e al biondo sotto la luce che filtrava tra le foglie in movimento. Si guardava intorno, respirando a grandi singulti ravvicinati, e ogni respiro le gonfiava enormemente la pancia, come un pallone. Il proiettile l’aveva colpita in basso, uscendo dall’addome.
Il marinaio Houston sentì lo stomaco lacerarsi. «Gesù Cristo!» urlò alla scimmia, come se le sue parole potessero modificare quell’imbarazzante e odiosa situazione. Pensò che gli sarebbe scoppiata la testa, se il mattino avesse continuato a bruciare la giungla circostante, se i gabbiani avessero continuato a gridare, se la scimmia avesse continuato a guardarsi intorno con circospezione, muovendo la testa e gli occhi neri da una parte all’altra come per seguire lo sviluppo di una discussione, di una disputa, di un litigio che la giungla, il mattino, il momento stavano conducendo con se stessi. Il marinaio Houston si avvicinò alla scimmia, posò il fucile lì accanto e la sollevò, con una mano sotto le natiche e l’altra sotto la testa. Si accorse, dapprima rapito, poi orripilato, che l’animale stava piangendo. Aveva il respiro rotto dai singhiozzi, e le lacrime gli sgorgavano dagli occhi a ogni battito di palpebre. Guardava qua e là, senza mostrare un particolare interesse per il marinaio. «Ehi» disse Houston, ma la scimmia non parve sentirlo.
Mentre la teneva in braccio, il suo cuore cessò di battere. Houston la scrollò, ma capì che era inutile. Ebbe la sensazione di essere colpevole di tutto, e lì, al riparo da sguardi indiscreti, si lasciò andare e pianse come un bambino. Aveva diciott’anni.
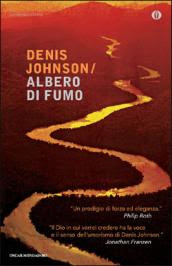
Nessun commento:
Posta un commento